
HOMEPAGE - pagine iniziale >>> www.puntopace.net

Carissimi, vi scrivo con gioia questa lettera circolare, le cui linee di
fondo erano state pensate per l’Avvento. Come vedete, è diventata una lettera
natalizia. Forse la troverete un
po’ insolita come lettera di Natale. Prendetela così com’è. Ho riassunto
alcuni miei pensieri sul tempo che passa, sul valore della vita e sulla venuta
tra noi di Colui che ne è l’Autore e la Meta. Ma l’ho fatto spingendomi
verso quei cancelli ultimi del pensare dove posso dialogare anche con chi non ha
una fede esplicita e professa… Vi troverete
anche riferimenti a mie recenti letture. Li offro come un piccolo regalo
natalizio a chi forse non ha tanto tempo per leggere. Qualcosa può sembrare più
difficile. Mi fu detto da qualcuno a proposito dell’ultima circolare su
distacchi e incontri. È vero, contrariamente a quanto cerco di fare di solito,
mediando con passaggi e termini più facili, non mi sono preoccupato troppo di
farlo allora. Forse nemmeno adesso. Spero di non essere del tutto
incomprensibile. Una vostra reazione è comunque sempre benvenuta. Un augurio
fraterno a tutti. Al resto della lettera premetto un titolo che mi è sembrato
significativo.
GUIDATI
DA UNA STELLA
Mario Luzi, ricevendo a Milano il premio Lazzati ha risposto all’apprezzamento del Card. Martini per la sua opera poetica (elogiata perché «intrisa di nostalgia della bellezza divina») con queste parole: «Il poeta sa che l'unica forma di conoscenza è il mistero. Il terreno del poetare è tra il conoscibile e l'inconoscibile, il dicibile e l'indicibile: il limite tra finito e infinito ci viene rappresentato proprio dal Cristo. È il Cristo che in un certo senso ha inventato l'uomo moderno, e lo ha superato in sé: è stato il dono del divino all'umano» (g.g.v.) [Corriere della sera, Giovedì, 25 Novembre 1999, pag. 47].
Queste parole mi ritornano ancora in mente mentre riordino i miei appunti scritti in treno alcune sere fa. Avevo annotato che l'avvento cade quest'anno a poche settimane prima della fine di un millennio e l'inizio del successivo. Così almeno si ritiene comunemente e convenzionalmente. Che un tempo finisca rientra nelle misurazioni adottate dall'uomo e non costituisce problema. Non dovrebbe di per sé nemmeno scatenare la febbre di fine millennio, che sta già contagiando buona parte del nostro pianeta. In quanto evento di una certa rilevanza sociale, ha interessato e continua ad interessare la religione cristiana che si trova coinvolta in questo tipo di misurazione, perché ha origine da una certa data presunta, quella della venuta nel mondo di Gesù il Nazareno.
La scansione del
tempo secondo sette settimane di anni porta a 49 e l'anno cinquantesimo con i
suoi multipli ripropone la sequenza biblica degli anni lavorativi
e del riposo previsto per l'anno giubilare. In realtà, come risulta dalle
infinite discussioni sul computo degli anni in questione, l'esattezza dei
calcoli non è proprio il meglio dell'intera discussione. Né personalmente ci
interessa più di tanto. Ci preme invece il significato che la sequenza
cronologica ha nel suo insieme, perché in essa appare un indiscutibile valore
antropologico, relativamente al senso del suo lavoro e del suo riposo, dei suoi
condizionamenti e della sua libertà. Di più: del suo vivere e del suo morire.
È a partire da quest'ultima considerazione che ci dobbiamo chiedere che significato diamo al tempo che inesorabilmente scorre via, trascinandosi con sé quanto abbiamo di più caro, dai nostri conoscenti e amici ai familiari, dalle cose belle acquistate o realizzate alla nostra stessa vita. D'altra parte, un tempo piatto che non scorresse mai sarebbe un'assurdità, non solo perché qualsiasi forma umanamente pensata di eternità è ostica persino da immaginare, ma anche perché è proprio il tempo che scorre a rendere la vita interessante. È ragione della nostra responsabilità nel mondo e rende sensata l'idea che la nostra esistenza corrisponde a un progetto e che ciascuno di noi ha una missione da portare a termine. Da portare a termine, appunto.
Ma di che missione si tratta? Non si può rispondere a questa domanda se non affrontando una questione preliminare, quella che riguarda la sensatezza della vita e delle cose che ci sono intorno. È come chiedersi se ha un valore la propria casa ed il proprio vestito, il pane che mangiamo e l’acqua che beviamo tutti i giorni. Per quanto la cosa possa apparire pacifica, non è detto che tutti la condividano. Anzi si potrebbe dire che coloro che hanno problemi ad ammettere il senso complessivo delle cose che abitiamo e dalle quali siamo abitati non sono proprio pochi, né sono le persone più insensibili. Al contrario, sono quelli che più rigorosamente si sono esaminati sul valore dell'intera realtà nel suo insieme. Ne hanno concluso che tutto è così vasto e al di sopra delle possibilità umane, al punto che non abbiamo strumenti sufficientemente validi per poter stabilire un senso globale omogeneamente valevole per tutto l’insieme che assomma ogni cosa. Siamo fatti - dicono - per il frammento e non possiamo superare i suoi limiti, giacché siamo anche noi solo un frammento. Il millennio che finisce potrebbe essere uno di questi frammenti? Disponiamo di strumenti di misurazione sufficienti almeno per questo? Francamente non so cosa risponderebbero. È certo però che la loro posizione è tutt'altro che da rigettare in maniera preconcetta.
Qualcuno di loro deduce quello che è stato chiamato “pensiero debole” dall’evento centrale del cristianesimo: il diventare debole di Dio nella vicenda di amore e di dolore di Gesù di Nazareth. Ritornare a questo evento, dandogli il valore di un paradigma e di un principio etico - aggiunge - potrebbe portare a superare le ricorrenti tentazioni che la Chiesa ha di sapere tutto e di volerlo imporre a tutti, in nome di una precristiana concezione dell’onnipotenza di Dio [Cfr. G. Vattimo, Credere di credere. È possibile essere cristiani nonostante la Chiesa? Garzanti, 1998].
L’intera questione rimanda comunque, paradossalmente, ad
un'affermazione che si potrebbe riassumere così: per capire il senso del tempo
bisogna essere al di fuori di esso, oppure bisogna lasciarsi istruire da
qualcuno che ne è fuori. È questo l’altro
pensiero, come ultima ancora di salvezza, invocato da M. Heidegger, quando
afferma: «Ormai solo un Dio ci può salvare. Ci resta, come unica possibilità,
quella di preparare (Vorbereiten) nel
pensare e nel poetare, una disponibilità (Bereitschaft)
all’apparizione del Dio o all’assenza di Dio nel tramonto (al fatto che, al
cospetto del Dio assente, noi tramontiamo)» [M. Heidegger, Ormai solo un Dio ci può salvare, (a cura di A. Marini), Guanda,
Parma 1987, 136].
Intuisco qualche possibile reazione: già, siamo alle solite. Dove non arriva la mente umana, invochiamo qualcuno che la supera: invochiamo Dio. Propriamente non si vuole intendere ciò. Se per Heidegger si tratta di intravedere altri inediti itinerari al di là della strada interrotta del pensiero sull’essere, per me - molto più modestamente - si tratta di fare un tentativo. Provare a spingere il discorso verso le sue ultime frontiere, per intravedere, se possibile, con la ragione ciò cui essa più che arrendersi ha la possibilità di aprirsi, anche se dovrà procedere, d'ora in poi, con altri mezzi che non sono più quelli rigorosamente derivati dalla ragione. Sono tuttavia il seguito di ciò cui essa è pervenuta. Ma per quale motivo? Se l'intera vicenda umana e persino cosmica abbia un senso è una domanda collegata con l'altra che reclama se il tempo abbia una fine e quale essa sia, alla pari della domanda se la fine dell'uomo abbia un senso e quale esso sia. Non è una domanda oziosa. È la madre di tutte le domande. Quello che io mi chiedo è anche quello che tu ti chiedi: se abbia un senso, e quale esso sia, che oggi in tanti abbiano pianto nel mondo, se abbia un senso e quale esso sia che bambini innocenti abbiano sofferto l'indicibile e che l'anziano solo abbia spento la luce della sua stanza, guardando nel vuoto senza più ricordi e senza farsi domande. È questa nostra miseria anche la miseria della nostra teologia? Tradiscono le nostre questioni una fondamentale, abissale povertà che non ci rassegniamo ad accettare? E - soprattutto - finita ogni cosa, spenta ogni vita umana sulla terra, prima che si spenga ogni altra stella o che riprenda ad esplodere in altre forme e forse in altre dimensioni (come dicono alcuni), si spegnerà proprio tutto e regnerà non già il «grande silenzio», ma il vuoto, spurio figlio del nulla e quindi del non ulteriormente interrogabile?
La poesia può ancora rispondere, ma non per offrire soluzioni, solo per indicare percorsi e orientamenti. Perché essa avvista lontananze che talvolta la ragione, nella sua piccolezza di orizzonti, non arriva a intravedere. Per farmi meglio capire, ricorro oggi ad un poeta tedesco della fine del 1700, Friedrich Hölderlin. Riprendo alcuni suoi versi nell’originale, per la gioia dei nostri amici tedeschi. Tenterò per gli altri una traduzione italiana, per quanto si possa ardire di tradurre dei versi:
Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind, /Ich dir noch kennbar bin, die Vergangenheit /O du Teilhaber meiner Leiden! /Einiges Gute bezeichnen dir kann […] Ancorché da lontano, giacché siamo separati, / tu possa intravedermi, / tu, compagno dei miei dolori, / il passato potrà mostrarti quel che di buono (era ed è tra noi) [...] (Wenn aus der Ferne…¸ in F. Hölderlin, Sämtliche Gedichte und Hyperion, Insel Verlag, Frankfurt a. M. 1999, 451).
Immagino questa lontananza non più come avversaria, ma come alleata, che con il suo richiamo ci fa trasalire e - soprattutto - fa affiorare alla superficie la nostra anima, quella delle persone amate e quella delle cose. Fa intravedere un’anima comune. È simile a quello spazio dell’Infinito, liricamente cantato dal nostro Leopardi, che diventa trepidazione e abbandono, sofferenza e resa incondizionata a ciò in cui siamo immersi, da errabbondi, e che non riusciamo ad abbracciare. Che non sia proprio in questa spina dell’incolmabile lontananza il segreto di quella parte dell’essere che non possiamo mai vedere, perché simile al lato oscuro della luna che ci sfugge nello stesso girarci intorno? È forse anche così del mistero della vita: nel mentre ci scorre intorno ci cela la sua faccia? Il pensiero di R. M. Rilke, che è sullo sfondo, propriamente si trova formulato così: «la morte è la faccia della vita a noi opposta e per noi non illuminata» (Briefe aus Muzot, 332: citato da M. Heidegger, Sentieri Interrotti, La Nuova Italia, Firenze, 279).
A fronte di questa distanza, remota essenza della vita, gli anni misurati con i nostri calendari sono ben poca cosa, eppure ne sono gli inevitabili passaggi. Spinti fino ai sentieri che tra le montagne s’interrompono [gli Holzwege heideggerriani], dobbiamo inerpicarci a vista e a nostro proprio rischio. Solo allora possiamo intuire le enormi lontananze che ci separano dagli altri e dalle cose eppure proprio allora intuiamo quel “qualcosa di buono” che cementa quell’incolmabile distanza e le nostre amare separazioni. Restando sulle tracce gli uni degli altri e soprattutto di quell’Uno che si è fatto Traccia e tale rimane tra noi, perché percorso di un Infinito non più ostile, di Cristo appunto, possiamo ancora affermare che non sta scritto da nessuna parte «che la storia umana, considerata all’interno del tempo (che la determina) debba semplicemente concludersi con la vittoria della ragione o della giustizia»? [J. Pieper, Noch nicht aller Tage Abend, München 1979].
Sì, considerando le cose dal di qua e dal di dentro del tempo, sembrerebbe - a prima vista - che non possiamo fare altro che cogliere esclusivamente un segmento di senso, sebbene enorme quanto la storia del cosmo - eppure ancora troppo piccolo per scavalcare i cancelli che lo delimitano oltre quel qualcosa che, paradossalmente, può essere il nulla e il tutto. Che cosa esso sia non lo sapremo mai, se non uscendo dal suo intimo meccanismo, che appare come la carica di un carillon, con un inizio e una fine, ma con una particolarità: finito il suo corso, la stessa molla si spezza e la musica non sarà più ripetibile. Solo dall’esterno del meccanismo riusciremo a sapere - afferma J. Ratzinger - che l’inizio e la fine del tempo non sono altro che “exitus” e “reditus”, uscita e ritorno, perché il ciclo si compia in Dio, dal quale ogni cosa proviene e al quale tutto ritorna. Nulla da eccepire. Purché questo recupero del modello del tempo, che fu anche di Tommaso d’Aquino, non faccia torto a quelle vittime della stessa storia e a quei trafitti dello scorrere del tempo che non il tempo in sé, ma poteri arroganti, ricorrenti sostitutivi di Dio nella storia, hanno provocato e lasciato insepolti nella memoria collettiva. È stata questa la risposta di J. B. Metz, l’ideatore della Teologia politica, al card. Ratzinger, nel dibattito organizzato dai suoi allievi in occasione del suo 70° compleanno [cfr. Petrs/Urban (Hg.), Ende der Zeit? Die Provocation der Rede von Gott, Grünewald Verlag, Maiz 1999].
A noi qui basti concludere che anche nell’aldiqua della storia non mancano le tracce di un Aldilà e che la poesia - sebbene tentennando e con gli occhi talvolta lucidi di pianto e di speranza - ancora riesce a intravederle. Anche e soprattutto per amore e come spinta in avanti di quel moto verso l’Infinito coltivato dai martiri, caduti nel passato, e che cadono sotto i nostri occhi smarriti, ancor più da un altro Natale già alle porte. Giovanni Mazzillo
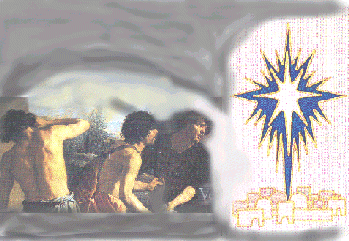
«Veniva
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. ... e si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di
unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità» (Dal Vangelo di Giovanni)
Con i più cari auguri per l’anno già
iniziato
In fraternità
d. G. MAZZILLO